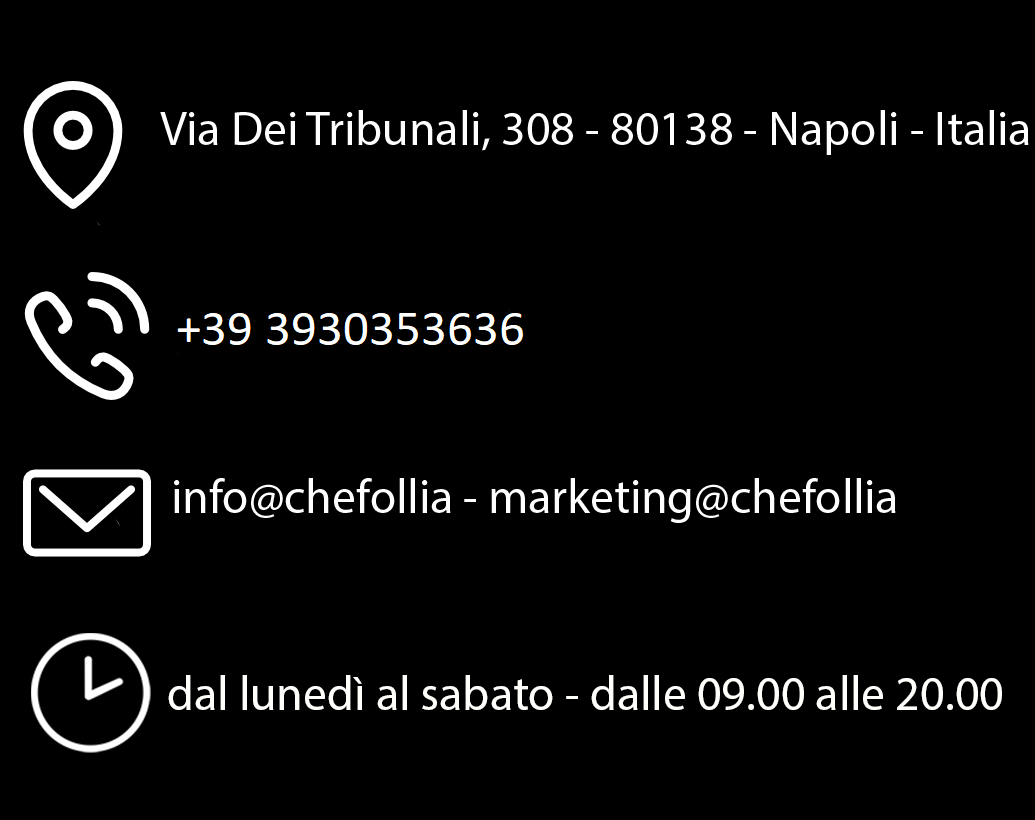Abbiamo parlato, nel precedente articolo, della disabilità come fatto sociale di fronte al quale occorre attivare una serie di trasformazioni in campo sociale, culturale e politico.
Vediamo ora quali sono state, negli anni, le soluzioni offerte alle persone disabili diventate adulte.
Nonostante siano tutte alternative ancora percorribili, alcune di esse, come già detto più volte, sono ormai quasi del tutto abbandonate poiché ne sono stati evidenziati limiti e problemi; altre sono, invece, in evoluzione e su queste mi interessa particolarmente soffermarmi.
Gli Istituti di ricovero
Le prime soluzioni proposte per la vita adulta degli handicappati furono individuate nel ricovero in istituto. Come per i bambini con handicap erano state istituite le scuole speciali, allo stesso modo si ritenne che la soluzione per gli adulti handicappati fosse un istituto che provvedesse ad assisterli, a rispondere alle loro esigenze di cura e di sopravvivenza.
Negli anni Sessanta che si osservò un incremento delle domande di ricovero per persone handicappate.
Agli istituti si rivolgevano le famiglie che non riuscivano, da sole, ad occuparsi del proprio figlio handicappato; non esistevano, infatti, in quegli anni, interventi di sostegno alla famiglia come una corretta informazione sull’handicap, un’assistenza psicologica e un aiuto concreto tramite l’assistenza domiciliare.
L’istituto rappresentava, inoltre, la meta obbligata per i portatori di handicap che rimanevano senza famiglia.
Il ricovero in istituto è stato, quindi, la conseguenza della mancanza e dell’insufficienza degli interventi socio-sanitari di prevenzione del bisogno assistenziale; prevenzione che si attua assicurando a tutti i cittadini, compresi quelli più deboli, le condizioni necessarie per un’esistenza fondata sulla massima
autonomia possibile dei singoli e dei nuclei familiari.
Per decenni lo Stato ha preferito riempire gli istituti, seguendo una politica di assistenza riduttiva, piuttosto che cambiare politica ed avviare un discorso di prevenzione, di creazione di servizi per i portatori di handicap e di integrazione.
In strutture così grandi e con così tanti ospiti ogni decisione veniva presa perché la struttura funzionasse nel miglior modo possibile e spendendo il meno possibile.
Tutto era pensato e progettato in funzione della struttura, del suo buon andamento e della sua conservazione, sia per motivi economici sia, talvolta, per motivi politici.
Si sono verificati casi di istituti tenuti in vita per esigenze politico clientelari poiché essi rappresentavano sacche elettorali.
Se, quindi, l’istituto risulta un buon rimedio per le famiglie in difficoltà e un buon affare per lo Stato, altrettanto non risulta per i portatori di handicap che devono viverci.
Il “ricoverato” in istituto si viene a trovare in un clima che non è familiare per via delle notevoli dimensioni; il vuoto creato dalla mancanza della famiglia viene amplificato dall’anonima vita che si conduce giornalmente: le esigenze del singolo non possono essere rispettate e i momenti della giornata sono uguali per tutti gli ospiti.
La stessa ubicazione, spesso, presentava un carattere emarginante perché, spesso, lontani dal luogo di origine degli ospiti, lontani dal loro contesto socioculturale.
Si è assistito, in questo modo, a un fenomeno di “deportazione assistenziale.
Gli effetti di questo sradicamento sul portatore di handicap sono sicuramente negativi e si sommano, così, i problemi dell’handicap con i problemi di uno spaventoso isolamento affettivo che porta nel tempo il soggetto ad una chiusura nei confronti degli altri.
Se si analizza la vita all’interno dell’istituto si trovano altri elementi emarginanti in aggiunta alla scelta dell’ubicazione.
Innanzi tutto elemento emarginante è la categorizzazione delle persone.
I portatori di handicap non vengono considerati come persone qualsiasi che hanno particolari problemi, ma vengono recepiti come facenti parte di una classe di handicappati (sordomuti, poliomielitici, ciechi, ecc.).
Vi sono poi aspetti della vita quotidiana che sono ben diversi dalla vita delle persone che vivono in famiglia: una grossa struttura può funzionare solo se supportata da un insieme di norme e regolamenti.
Sono stabiliti gli orari in cui mangiare, quelli in cui dormire, quelli in cui divertirsi, ecc., e questi orari diventano immutabili per mantenere un certo ordine nella struttura.
Tale rigidità non può non calpestare i bisogni di ogni singolo ospite.
Per i numerosi ospiti che affollavano gli istituti non c’era la possibilità di avere una vita privata, momenti di intimità.
La mancanza di libertà, che si concretizza nell’impossibilità da parte delle persone con handicap di effettuare scelte personali all’interno dell’istituto, era ben evidente. Tutto ciò a facilitare l’appiattimento, il conformismo, negando ogni possibilità di assumersi delle responsabilità e di vivere come altri individui adulti.
Non ci troviamo, quindi, di fronte ad una struttura che favorisce la crescita e la maturazione degli individui che ospita, ma che, al contrario, per come è organizzata e per ciò che offre, porta spesso ad un peggioramento della situazione del portatore di handicap. Basti già il fatto che la mancanza di integrazione e la copresenza di numerosi handicappati all’interno dello stesso spazio non aiuta gli ospiti ma favorisce, invece, in ognuno di loro, l’acquisizione di comportamenti problematici manifestati dagli altri.
Secondo la famosa antropologa americana Margareth Mead, il ricovero in istituto non è altro, in rapporto alle pratiche primitive, che un mezzo per sbarazzarsi, nelle forme ammesse, dei bambini di cui nessuno vuole occuparsi. L’antropologa sostiene che nelle società primitive non esistevano istituti, ma tutto ricadeva sulla famiglia, sulla tribù, sui vicini. Quando ai bambini non si poteva garantire una vita degna, li si sopprimeva. Per la società di oggi questo è inaccettabile; lo Stato deve garantire ad ogni bambino, qualunque sia la sua condizione, la sopravvivenza: è questa un’etica che la Mead chiama “impersonale” (nessun bambino deve morire), che si contrappone all’etica “personale” (il bambino deve essere protetto).
C’è, quindi, un etica impersonale alla base della cultura dell’esclusione e dell’istituzionalizzazione e di quegli atteggiamenti più o meno espliciti che tengono ai margini della società chi genericamente non è considerato normale.
La creazione di spazi propri e protetti per specifici gruppi (handicappati, anziani, devianti), se da un lato aiuta a risolvere problemi urgenti ed emergenti, dall’altro determina dinamiche di esclusione quasi sempre irreversibili, proprio perché viene definito uno spazio fisico e psicologico separato, lontano dalla responsabilità e dal coinvolgimento dei cittadini.
E’ importante tenere ben presenti i danni che l’istituzionalizzazione ha arrecato alle persone con handicap, e non solo a loro; tutto ciò ha portato negli anni ad un controllo negli istituti esistenti e, di conseguenza, ha costretto lo Stato a cercare di realizzare delle strutture alternative.
L’istituto non è l’unico luogo segregante in cui venivano ricoverati gli handicappati: un’altra soluzione adottata era quella per la vita adulta dei disabili del ricovero in Ospedale Psichiatrico.
Negli ospedali psichiatrici, previsti dalla legge Giolitti n. 36 del 14/02/1904, sin dalla loro istituzione sono stati ricoverati, oltre che malati di mente, anche persone con epilessia, sindrome di Down, spasticità, distrofia, cecità, sordità.
La legge, infatti, prevedeva che chi fosse ritenuto “pericoloso a sé e agli altri e di pubblico scandalo”, dovesse ricadere sotto la competenza psichiatrica e quindi essere internato in manicomio.
Evidentemente, in questa definizione di pericolosità sono stati fatti rientrare coloro che presentavano delle diversità rispetto alla gente “normale” e che non avevano un posto dove andare perché la famiglia li allontanava o non esisteva affatto.
Il ricovero era possibile solo sotto forma di provvedimento del magistrato o del questore (si veniva ricoverati dalla polizia); il direttore del manicomio era responsabile penalmente e civilmente del paziente dimesso. In tale regime, nella stragrande maggioranza dei casi, i disturbi dei ricoverati diventavano cronici.
La situazione determinata dall’applicazione della legge Giolitti si consolida successivamente a seguito dell’entrata in vigore di nuove disposizioni che rinsaldano ulteriormente il sistema manicomiale in ragione del loro carattere repressivo.
La legge Giolitti, a causa della sua incompatibilità con la Costituzione della Repubblica Italiana (1948) venne abrogata solo nel 1978 con la legge n. 180 che prevede l’abolizione dei manicomi grazie all’encomiabile attività di uno psichiatra di ampie vedute, Franco Basaglia, che ebbe il solo torto di essere morto troppo presto per potere attuare compiutamente le sue teorie innovative e progressiste.
Tuttavia già dal 1968 l’istituzionalizzazione in campo psichiatrico viene messa in discussione, sia per le lotte contro la selezione e la discriminazione sociale di quegli anni, sia per l’esplosione a livello di opinione pubblica di casi particolarmente traumatizzanti.
Viene, così, approvata una nuova legge, la 431 che stabilisce l’insufficienza dell’assistenza psichiatrica basata esclusivamente sull’internamento in manicomio e prevede la creazione di strutture exra- ospedaliere radicate sul territorio; abolisce, inoltre, l’obbligo di annotare nel casellario giudiziario l’ammissione e la dimissione dal manicomio e istituisce il regime di ammissione volontaria basato sulla richiesta di ricovero da parte dell’infermo stesso.
Lo sconvolgimento provocato da queste lotte contro l’istituzionalizzazione, il rifiuto del modello stesso di “normalità”e quindi della selezione del “diverso”, che inizialmente nasce in ambito psichiatrico da parte degli operatori stessi, finisce poi per estendersi e coinvolgere tutti gli altri settori dell’assistenza
(handicappati, bambini, anziani) fino ad allora ruotanti intorno al ricovero in istituto.
Si arriva, così, a mettere in discussione la funzione dell’istituto in quanto tale, come strumento non curativo, di emarginazione, che, dietro l’apparenza di un’assistenza globale e protettiva, reprime e occulta i disturbi, danneggia la vita psichica oltre a far, di fatto, regredire il ricoverato.
Nasce in questi anni un dibattito in cui vengono coinvolti genitori, insegnanti, operatori sociosanitari e forze politiche che porta ad una legislazione che più si avvicina a quei principi sanciti dalla Costituzione sin dal 1948.
La legge 180 sancisce la fine del manicomio e impone il ribaltamento della logica su cui deve fondarsi l’assistenza. La preoccupazione del legislatore non è più solo quella di proteggere la società dal “diverso” creando una barriera tra l’uno e l’altra: l’obiettivo è di predisporre strutture e servizi diffusi e diversificati nel territorio, spesso sotto forma di assistenza domiciliare, che consentano al cittadino di vivere la propria esperienza di “crisi” mantenendo i rapporti con la collettività di cui fa parte.
In sostanza la legge 180 obbliga ogni regione a superare gradualmente i propri manicomi sostituendoli con una rete di nuovi servizi che, prescindendo dall’internamento ed assumendo una dimensione prevalentemente territoriale, non si limitano alla cura, ma svolgono anche prevenzione e riabilitazione. Ne consegue il superamento del concetto di pericolosità del folle, che aveva determinato e mantenuto in piedi l’apparato di custodia dei manicomi. Inoltre, il paziente è un cittadino che conserva i suoi diritti: primo fra tutti quello di non essere allontanato dal suo abituale ambiente di vita.
Altro importante concetto espresso dalla legge 180 riguarda il principio della volontarietà: i trattamenti sanitari devono essere normalmente consentiti dall’interessato, e soltanto in casi estremi gli possono essere imposti obbligatoriamente, fatto salvo comunque il rispetto di procedure garantiste che assicurino la controllabilità dall’esterno dell’intervento applicato.
Con la chiusura degli ospedali psichiatrici è stato necessario allargare il concetto di terapia: in passato si cercava di isolare la malattia in manicomio, lontano dalle cause di disturbo e dalle interferenze della vita; oggi si osservano e si curano le persone nella loro interezza storica, sociale, familiare e culturale, si è passati dalla cura della malattia alla cura della persona malata. A seguito dei nuovi trattamenti, all’uscita dal manicomio, un’alta percentuale di soggetti ritenuti inguaribili hanno potuto riprendere abitudini di vita non più praticate, o comunque ritenute irrecuperabili. Molti, al di là di ogni aspettativa, sono stati messi in condizione di raggiungere un livello di vita soddisfacente.
Il 22 Aprile 1994 è stato pubblicato un Decreto del Presidente della Repubblica dal titolo “Approvazione del Progetto Obiettivo Tutela della Salute Mentale” che chiarisce definitivamente che l’Ospedale Psichiatrico deve essere integralmente sostituito dal Dipartimento di Salute Mentale,
chiarendone funzioni ed organizzazione.
Nonostante i vari propositi, però, a vent’anni dalla promulgazione della legge 180 il processo di superamento dei manicomi non si è ancora concluso: si sono operate finte chiusure o trasferimenti in altre istituzioni, talvolta, non migliori di quelle manicomiali; la nascita di strutture intermedie è stata ritardata per anni e rischia in molti casi di essere solo una finzione, specialmente quando vengono collocati pazienti in numero eccessivo, oppure quando si recuperano strutture territorialmente isolate.